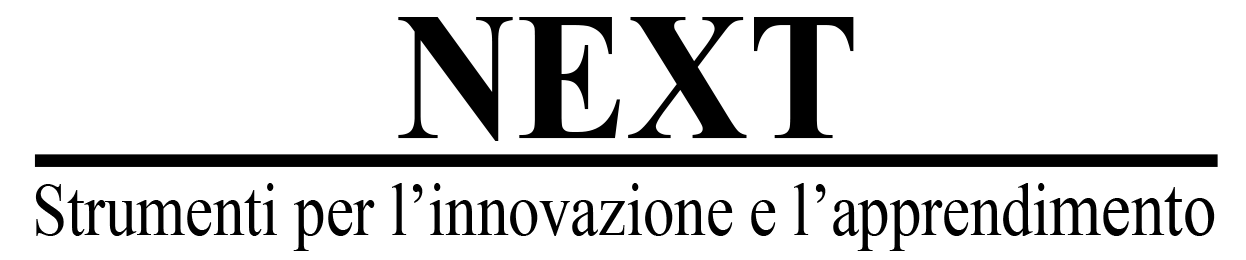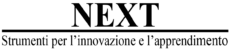di Paolo Macry
L’Italia repubblicana non ha avuto un grande partito conservatore, il partito liberale di massa che vagheggiava Giovanni Malagodi. Al contrario, dire destra ha spesso significato, nel discorso pubblico, evocare tentazioni autoritarie
Ora che a palazzo Chigi siede il primo governo di destra della repubblica, gli osservatori politici cercano di leggere nella sfera di cristallo. Quale futuro predirgli? Sarà l’inizio di una stagione o una parentesi? E Giorgia Meloni, sarà una meteora o entrerà nella storia come De Gasperi, Craxi, Berlinguer? Ma capirci qualcosa non è facile, perché gli scenari sono nuovi di zecca. E non basta, probabilmente, interpretare gli indizi offerti dalla cronaca, il responso delle elezioni regionali, i sondaggi di Enrico Mentana, le piccole tempeste quotidiane dello scontro politico. Qualcosa di meno episodico, forse, può ricavarsi da uno sguardo alla storia della destra nel dopoguerra (*). Una storia (ed è già significativo) che appare molto diversa da quella delle altre destre europee, da quella dei grandi partiti conservatori europei di estrazione liberale. L’Italia repubblicana non ha avuto un grande partito conservatore, non ha avuto il partito liberale di massa che vagheggiava Giovanni Malagodi. Al contrario, dire destra ha spesso significato, nel discorso pubblico italiano, evocare pulsioni antidemocratiche, tentazioni autoritarie. Evocare, in una parola, il fascismo. Del resto, non essendo mai stato storicizzato fino in fondo, il fascismo rimane, agli occhi della sinistra, una sorta di eterno pericolo, lo spettro che grava sul paese come fosse una tara.
L’assenza di un partito conservatore nella Prima Repubblica
Come si sa, la storia della destra nel dopoguerra va divisa in due tempi ben distinti. Prima e dopo il 1994, prima e dopo la svolta che portò per la prima volta a palazzo Chigi Silvio Berlusconi. E di certo, nel mezzo secolo che intercorre tra 1945 al 1994, non fu una storia facile. La destra contava, al tempo, posizioni ideologiche e culture politiche assai diverse tra loro, dal neofascismo saloino al liberalismo di origine risorgimentale, dai qualunquisti di Guglielmo Giannini ai monarchici. Erano destre, più che una destra. Tutte, però, dovettero affrontare il problema lungamente insormontabile di una delegittimazione politica e culturale che nasceva da colpe storiche indubitabili ‒ la dittatura mussoliniana, la sconfitta bellica ‒ e che finì tuttavia per colpire non soltanto il Movimento Sociale Italiano, il partito dei reduci fondato nel 1946, ma anche quella numerosa opinione pubblica che annoverava nelle proprie file i conservatori, i moderati, i nostalgici della monarchia, gli anticomunisti, i molti italiani che avevano abbandonato il fascismo ma non si sarebbero mai definiti antifascisti, i molti meridionali che erano stati risparmiati dalla guerra civile e non avevano partecipato alla Resistenza. Certo è che un intero «paese di destra» venne spinto nelle accoglienti praterie del partito cattolico, di quella Democrazia Cristiana al cui interno convivevano componenti conservatrici e componenti di sinistra, De Gasperi e Dossetti, la Chiesa di Pio XII e la Chiesa di Giovanni Battista Montini. E nelle elezioni del 18 aprile 1948, grazie alle potenti organizzazioni ecclesiastiche, i giochi sembrarono fatti: in mancanza di meglio, quell’opinione pubblica che non amava più il fascismo, ma tanto meno amava la sinistra socialcomunista, si riversò sulla Dc, unica affidabile «diga anticomunista». Al confronto, i partiti di destra apparivano deboli, emarginati dal gioco parlamentare, ininfluenti, e furono perciò prosciugati elettoralmente dal partito cattolico, che diventò ‒ e rimase per decenni ‒ il partito di maggioranza relativa.
L’Italia conservatrice e moderata, tuttavia, aveva preso a votare la Dc «turandosi il naso», come disse Indro Montanelli, non apprezzando il suo lambiccato linguaggio politico, non amando i suoi leader, Moro, Fanfani, Andreotti. Era una sorta di scelta obbligata. Ma segnalava un singolare deficit di rappresentanza che, alla lunga, avrebbe minato l’intero sistema politico. Quel paese di destra, che si percepiva messo ai margini dall’Italia antifascista e repubblicana, finì per maturare un sentimento di estraneità rispetto alle classi dirigenti del paese, di diffidenza nei confronti dei partiti, di sorda ostilità verso la politica e il gioco parlamentare. Un’attitudine che si sarebbe accentuata quando la Dc, cercando di consolidare la propria maggioranza, decise di aprirsi alle formazioni di sinistra e si alleò negli anni Sessanta con il Psi di Pietro Nenni e poi, negli anni Settanta, con il Pci di Enrico Berlinguer. Portando così a sinistra i voti di destra che aveva in pancia. Inevitabilmente il deficit di rappresentanza si aggravò, crebbe la distanza tra il paese e le sue classi dirigenti, montò l’onda dell’antipolitica. Tanto più che le performance dei governi sembravano alle corde. Gli anni del «miracolo economico» erano ormai un ricordo. Nel tardo Novecento, l’Italia aveva imboccato il circolo vizioso della «crisi fiscale», la spesa in deficit cresceva a dismisura, l’inflazione era a due cifre, peggioravano i conti dello Stato, aumentava il debito pubblico. E gli esecutivi di centrosinistra cercavano di mantenere il consenso elettorale attraverso un welfare talvolta demagogico e costoso, facendo lievitare le imposte. Emergeva lo scontento delle regioni più produttive, la tradizionale «questione meridionale» veniva surclassata da una nuova «questione settentrionale». Il paese era inquieto. Furono gli anni degli attentati al tritolo e del terrorismo «rosso» e «nero». Il ceto politico reagì, sconfiggendo gli «opposti estremismi», ma era sempre meno popolare. Il fiume carsico dello scontento si preparava a sommergerlo.
Il crollo del sistema partitico e l’emersione della destra
E quando, dapprima con la fine del comunismo sovietico e poi con le inchieste giudiziarie di Mani Pulite, crollarono i partiti che erano stati il pilastro della repubblica, dal Pci alla Dc e al Psi, ecco che venne alla luce del sole il paese di destra. Quei suffragi, che per decenni si erano nascosti dietro la «diga anticomunista» della Balena Bianca, sembrarono finalmente liberi di votare senza catene ideologiche. Ma anche per chi uscì vittorioso dal collasso del 1991‒1993, fu un lieto fine soltanto in parte. Se i piccoli partiti di destra della prima Repubblica erano stati messi nell’angolo dalla conventio ad excludendum, i grandi partiti di destra della seconda Repubblica nacquero in un panorama di macerie politiche. Nacquero dopo un fenomeno precoce di quella che, anni dopo, si sarebbe chiamata disintermediazione. E non era un buon viatico.
Le difficoltà strutturali della Seconda Repubblica
Oggi destra e sinistra fanno a gara nel rinfacciarsi le reciproche divisioni interne. E divisioni ne esistono realmente, profonde, talvolta storiche. L’attuale opposizione annovera tra le proprie file postcomunisti, socialisti, popolari, liberali, ambientalisti, grillini, e fatica perciò a trasformarsi in una credibile alternativa. La maggioranza, per parte sua, sebbene compattata dal successo elettorale e dalla conquista del governo, ha referenti sociali, programmi, culture politiche che appaiono difformi e talvolta incompatibili.
Ma il problema non nasce oggi. Al contrario, la simmetrica disomogeneità di maggioranza e opposizione è uno dei principali caratteri della seconda Repubblica. Una sorta di Sonderweg ‒ o, meglio, una vera e propria patologia ‒ che sarebbe opinabile addebitare alle scelte mutevoli degli elettori, alla loro scarsa partecipazione civica, a qualche presunta antropologia viziosa degli italiani. I quali in realtà, come in ogni democrazia rappresentativa, votano quel che propone loro l’offerta politica. Ed è l’offerta politica che appare assai problematica, in Italia, da trent’anni a questa parte, dalla «grande slavina». Da quando cioè l’intero sistema dei partiti, su cui era vissuto il paese nei precedenti cinquant’anni, si dissolse con eccezionale rapidità e scomparvero pressoché tutte le organizzazioni che tradizionalmente costituivano il tramite fra cittadinanza e politica. Fu una drastica disintermediazione. Gli italiani vennero lasciati soli con se stessi, per così dire, e, quando furono chiamati alle urne, nel 1994, trovarono sulla scheda un’offerta politica in gran parte nuova e, per molti versi, anomala. L’alternativa alla prima Repubblica era, per la prima volta dal 1945, una destra con ambizioni di governo. Ne facevano parte un partito inventato dal tycoon Silvio Berlusconi nel giro di pochi mesi (Forza Italia), un partito «settentrionale» a forte ispirazione autonomistica (la Lega Nord), un partito radicato invece nelle regioni meridionali e ancora incerto sulla Costituzione antifascista (Alleanza Nazionale‒Movimento Sociale Italiano). E, per quanto improvvisata, l’alternativa vinse. Il paese intendeva voltare pagina. La tradizionale diffidenza di ampi settori di opinione verso i partiti storici e verso la stessa politica si tramutò in una pronta disponibilità nei confronti delle novità che venivano proposte. Le quali raccolsero oltre sedici milioni di voti. L’Italia delle grandi chiese politiche, della subcultura comunista, delle reti democristiane, delle sezioni di partito, della militanza diffusa, della «cinghia di trasmissione» sindacale era scomparsa una volta per tutte.
E furono inventate su due piedi, complici le norme elettorali, anche le coalizioni. Il paese entrò nella stagione dell’alternanza e sembrò la conquista di un’agognata normalità. Ma i partiti erano quello che erano ‒ assai diversi dalle macchine organizzative del passato ‒ e l’inefficiente bipolarismo della seconda Repubblica ne fu la conseguenza. Centrosinistra e centrodestra si rivelarono ad egual titolo alleanze incoerenti, disomogenee, strumentali. Berlusconi aveva avuto l’abilità di mettere assieme liberali e postfascisti, liberisti e statalisti, federalisti e nazionalisti, nordisti e sudisti, garantisti e securitari. Ma questa fu anche la sventura dei suoi governi, che furono dilaniati da conflitti interni espliciti o sotterranei e immobilizzati da istanze incompatibili. Anche l’altro polo, del resto, il centrosinistra, soffrì le spinte particolaristiche delle sue molte anime e alla fine ne fu sconfitto. Con simili coalizioni, se era possibile vincere le elezioni, assai meno si riusciva a governare. La seconda Repubblica entrò rapidamente in crisi, i suoi esecutivi persero la fiducia popolare di cui avevano goduto nel 1994. Le promesse mirabolanti restarono al palo, fallì la «rivoluzione liberale» di Berlusconi, fallì l’estremismo secessionista di Bossi, fallì il tentativo di Fini di dare al paese un partito conservatore. Il declino del sistema Italia diventava inarrestabile, con la crisi della produttività, la malattia del corporativismo, l’ipertrofia burocratica, le défaillance delle Regioni, le mitiche riforme eternamente rimandate. E, ancora una volta, l’elettorato sembrò capire ‒ e disapprovare ‒ i gravi limiti della politica. Fu perciò un elettorato sempre più tentato dall’astensionismo, un elettorato volatile, senza tessere di partito, difficilmente fidelizzabile, pronto ad accogliere ‒ per disperazione? ‒ qualsivoglia novità gli venisse proposta. Arrivò così l’onda populista del movimento fondato da un comico di successo, Beppe Grillo, e da un imprenditore dell’informatica, Giandomenico Casaleggio. Le piazze del «vaffa» si riempirono di folle entusiaste e le urne, nel 2018, si riempirono di undici milioni di voti ai Cinque Stelle. Il fiume carsico della protesta e della disaffezione civica riemergeva con forza. Cresceva l’ostilità nei confronti delle classi dirigenti. Della «casta», come si cominciò a dire con disprezzo. Anche le destre della seconda Repubblica, cui per anni era andata la responsabilità di governo, avevano deluso le aspettative.
Le sfide della leadership di Giorgia Meloni
Giorgia Meloni è figlia di questa storia. Ha promosso una formazione politica che riflette i limiti di organizzazione e di radicamento di tutti i partiti della seconda Repubblica. E naturalmente tornare ai modelli del Novecento ‒ ai grandi partiti conservatori europei ‒ sembra illusorio. Ma anche accontentarsi di un partito liquido potrebbe essere rischioso. Al tempo stesso, Meloni deve misurarsi con una coalizione afflitta dai nodi politici e normativi che hanno caratterizzato il bipolarismo immaturo degli ultimi trent’anni. Spetta a lei amalgamare le istanze diverse e talvolta divergenti dei partiti e delle culture politiche che compongono ‒ tradizionalmente e ancora oggi ‒ la destra italiana. E spetta a lei governare «da destra» un paese che ha spesso avuto difficoltà a legittimare la destra e altrettanto spesso, più o meno strumentalmente, l’ha confusa con il fascismo. Oggi la premier sembra avere l’opportunità di tradurre in concrete policies un profilo culturale e ideologico che sia alternativo al «progressismo», ma adeguato ai tempi e non reazionario. Ma l’operazione non è facile, come dimostra un certo altalenare del governo fra centralismo e regionalismo, statalismo e mercato, Stato di diritto e securitarismo, tradizionalismo e innovazione. Tanto più che, a fronte delle vistose criticità del paese, è necessario muoversi all’interno delle norme stabilite dall’Unione Europea. Dopotutto, a partire dal 1994, la destra italiana è andata al potere in condizioni assai diverse da quelle che videro la lunga egemonia della Dc e dei suoi alleati di sinistra. Allora, prima di Maastricht, si potevano promuovere politiche sociali, economiche, finanziarie che oggi sono precluse a Meloni, come a qualunque governo del Vecchio Continente, a causa dei vincoli europei. La stessa raccolta del consenso è diventata più difficile. Non si può più addebitarne i costi alle casse pubbliche. E più difficile è diventato di conseguenza il rapporto dei partiti ‒ di questi fragili partiti ‒ con i propri referenti sociali.
Riconquistare la fiducia degli italiani nella politica
Ma forse è un altro ancora il problema principale che attende la destra. Meloni è arrivata a palazzo Chigi dopo anni di opposizione parlamentare, cogliendo cioè il vento della protesta, utilizzando la permeabilità dell’opinione pubblica ai linguaggi del populismo, infierendo non di rado sulle défaillance dei governi e delle istituzioni. Oggi, tuttavia, per conquistare una prospettiva durevole alla propria leadership, sembra costretta a cambiare registro, cercando piuttosto di recuperare la fiducia degli italiani nei confronti della politica. Invertendo una tendenza antipolitica che, come un filo rosso, affonda le radici nelle vicende repubblicane e prima ancora nel ventennio fascista, e che spesso ha visto come protagoniste le destre. Dai qualunquisti di Giannini ai monarchici di Achille Lauro, dai neofascisti della rivolta di Reggio Calabria fino all’antistatalismo etnico della Lega Nord e al populismo liberale di Berlusconi. Delle onde antipolitiche che hanno terremotato la seconda Repubblica, Giorgia Meloni ha fatto largamente uso quando sedeva sui banchi dell’opposizione. Ma da palazzo Chigi le sarebbe difficile costruire un «partito della nazione» senza affrontare le ferite strutturali e culturali che la demagogia ha inferto al paese.
(*) Su questi temi rimando a Paolo Macry, La destra italiana. Da Guglielmo Giannini a Giorgia Meloni, Laterza 2023.