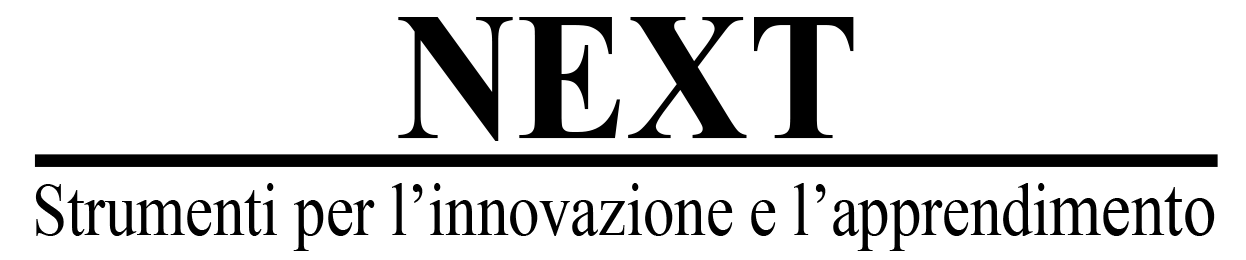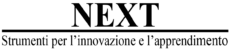di Marco Demarco
Meglio i Comuni che le Regioni. Anzi, meglio i Comuni senza Regioni. Lo si sente dire sempre più spesso. E sempre più spesso c’è chi si dichiara pronto a scommettere sui sindaci. Ma è proprio così che stanno le cose? Davvero l’Italia dei Comuni, quella degli asili nidi, del trasporto pubblico e dei servizi sociali, è migliore, cioè più vivibile e meno diseguale, dell’Italia delle Regioni, delle Asl in affanno, delle liste di attese e del turismo sanitario sulla direttrice Sud-Nord?
Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è ovviamente di questo avviso. Non a caso parla delle Regioni come di «istituzioni che non sempre sono state in grado di affievolire i divari in termini di qualità della vita» e che hanno anzi provocato «criticità note a tutti nei settori che riguardano l’economia, il lavoro, i trasporti, la sanità e il welfare». Ma è stato un altro sindaco, Gaetano Manfredi, parimenti critico del regionalismo italiano, ad ammettere dalla sua Napoli, coraggiosamente, tra l’altro, che anche le città hanno i loro divari interni e i loro servizi mal distribuiti tra centro e periferia.
E dunque qualche dubbio viene sulle magnifiche sorti e progressive dei Comuni, su quella che viene indicata come una loro oggettiva «diversità istituzionale». Specialmente dopo aver letto un libro come «L’Italia differenziata. Autonomia regionale e divari territoriali» (Rubbettino editore) di Vittorio Daniele e Carmelo Petraglia. Entrambi esperti di politiche di coesione, Daniele insegna economia dello sviluppo all’Università Magna Graecia di Catanzaro, Petraglia insegna economia politica all’Università della Basilicata ed è tra i coordinatori dei rapporti Svimez. Il loro grande merito è di aver rielaborato dati ufficiali dell’Istat, della Ragioneria della Stato, dell’Ufficio parlamentare di bilancio, di organismi internazionali come l’Ocse, e di averli resi funzionali a una aggiornata riflessione sull’Italia diseguale. Ma attenzione: portare in giudizio i Comuni non vuol dire assolvere le Regioni, a cui gli stessi autori dedicano pagine e pagine il cui tono va dal critico all’allarmato. Vuol dire solo mettere meglio a fuoco il problema per non vivere di false illusioni, per non vedere, come Pangloss, mondi migliori dove non ci sono. Insomma, perché mai i Comuni che non sempre e non ovunque riescono a offrire buoni servizi e ben distribuiti sui proprio territori dovrebbero far meglio se lasciati soli sul campo? I dati e i fatti, allora. A cominciare dal quadro di fondo.
La diseguaglianza tra Comuni: risorse e servizi
I Comuni non sono tutti uguali, ci sono quelli con residenti più ricchi e quelli con residenti più poveri. E poiché nei bilanci comunali, circa un terzo delle entrate proviene da tasse e imposte, questo, alla lunga, ha prodotto una frattura insanabile tra Comuni ricchi sempre più ricchi e Comuni poveri sempre più poveri. Da qui il ricorso a trasferimenti perequativi da parte dello Stato e delle Regioni; trasferimenti tesi a correggere sempre più, ma non ancora del tutto, il criterio «rigido» della spesa storica.
Si arriva così all’ultimo triennio monitorato, quello 2019-2021, in cui gli enti locali meridionali hanno ricevuto, in termini pro capite, trasferimenti statali maggiori di quelli settentrionali. Ciò nonostante, la qualità dei servizi non è migliorata. Come mai? Per tante ragioni, naturalmente. Ma tra queste ce n’è una particolarmente rilevante: i Comuni che «ricevono» di più sono anche quelli che spendono di meno per i servizi. In Calabria, ad esempio, per ogni residente sono entrati nelle casse comunali 945 euro, quanti in Lombardia, ma più che in Emilia-Romagna (927 euro). In Abruzzo 887, più del Piemonte (855). In Campania 820, quanti in Veneto. Mentre sul fronte delle spese, succede che i Comuni campani spendono 575 euro, meno del Veneto (634) e quelli calabresi meno dei lombardi (689 contro 794). E così che i Comuni del Centro-Nord si ritrovano con più del doppio degli asili nido di quelli del Sud e anche con più del doppio degli assistenti sociali. Mentre il servizio di assistenza domiciliare agli anziani è assicurato dal 92% dei Comuni del Nord e solo dal 69% di quelli meridionali (addirittura 38% in Calabria).
Federalismo fiscale e il nodo dell’evasione
E ora torniamo al punto. Può bastare questo dato strutturale a spiegare tutto? A spiegare, cioè, un’Italia comunale ancora così diseguale e così diversamente efficiente? Daniele e Petraglia tendono a escluderlo e chiamano in causa altri fattori. Valutano, ad esempio, che su 1.300 procedure di dissesto e di riequilibrio finanziario attivate tra il 1989 e il 2023, ben 1.027 (il 79%) hanno riguardato enti meridionali. O che nel 2022 il numero di dipendenti comunali per mille abitanti è stata, in media, più basso nel Mezzogiorno peninsulare (4,3), rispetto al Nord (5,8) e al Centro (6,3), con le eccezioni delle regioni a statuto speciale Sicilia (7,8) e Sardegna (6,5) e della Calabria (6,1). Ma notano anche che nei Comuni meridionali l’incidenza della spesa per l’autoamministrazione (cioè per l’insieme della gestione) è mediamente maggiore di quella degli enti del Centro-Nord. E che gli esborsi per interessi e per ripianare i debiti pregressi sono maggiori nei Comuni del Sud. In modo particolare, notano poi che c’è un altro problema serissimo con cui fare i conti. È quello dell’evasione fiscale connessa alla mancata riscossione delle imposte. È un problema che riguarda l’intero Paese, come ha sottolineato il ministro Giorgetti, quando audito sul federalismo fiscale al Senato il 10 luglio, ha detto che «l’ammontare dei residui attivi dei Comuni è salito da 74 miliardi del 2020 a 85 miliardi nel 2022 (da 32 a 35 miliardi i crediti dubbi)». Ma nei Comuni del Sud – specificano Daniele e Petraglia – la differenza tra gettito teorico e gettito effettivamente incassato è più alta che altrove e anche questo è un elemento rivelatore molto importante. Parlano chiaro i dati relativi all’Imu del 2021. Il tax gap è stato del 40% in Calabria, del 34% in Campania, del 33% in Sicilia e circa dell’11% in Emilia-Romagna e Valle d’Aosta. E non a caso di recente c’è stato anche un allarme della Corte dei conti, che ha messo sotto osservazione le segnalazioni di anomalie, provenienti dai Comuni, relative al pagamento dei tributi statali come l’Irpef, l’Irap e l’Iva. Risultato: nel 2014 i Comuni hanno fatto 2.700 segnalazioni all’Agenzia delle entrate, ricevendo in premio oltre 21 milioni di euro; nel 2023 le segnalazioni dello stesso tipo sono precipitate ad appena 480. Di conseguenza sono andate giù anche le somme recuperate: da 21 a 4 milioni, di cui quasi la metà sono andati a Genova e 736.000 a Milano. E non per chissà quale recondita ragione, ma semplicemente perché i Comuni di Genova e Milano sono stati quelli che hanno segnalato di più. Il meccanismo, infatti, prevede che l’incasso totale sottratto all’evasione vada allo Stato e che una quota percentuale torni ai Comuni che hanno contribuito al recupero. Ma i Comuni che nell’ultimo anno si sono realmente attivati sono stati solo 260, pari ad appena il 3% del totale. «Un apporto del tutto marginale» ha chiosato la Corte dei conti, appuntando al petto dei sindaci una medaglia che certo di valore non è. La causa di tanto disimpegno è facile da individuare. Dal 2022, lo Stato ha smesso di versare ai Comuni l’intero ammontare dell’evasione recuperata. E poiché ora trasferisce solo il 50% è probabile che molti sindaci abbiano deciso di non darsi da fare per così poco.
Un’Italia comunale davvero efficiente?
La riforma del federalismo fiscale, prevista già dalla legge del 2009 e inclusa anche dal Pnrr, dovrebbe comunque mettere ordine al complesso rapporto tra centro e periferia dello Stato. Ma domani è un altro giorno. Per quanto riguarda l’oggi restano invece le conclusioni a cui sono giunti Daniele e Petraglia. «Le differenze nei servizi tra i Comuni del Mezzogiorno e del Centro-Nord – scrivono – possono essere spiegate da diversi fattori. In alcuni casi, dalle diverse disponibilità di risorse finanziarie e di personale qualificato; ma questa non è certamente l’unica spiegazione. Nel Mezzogiorno, per i disavanzi accumulati e per la bassa capacità di riscuotere le imposte, molti Comuni versano in condizioni finanziarie critiche, mentre la composizione della spesa è sbilanciata su funzioni diverse dalla fornitura dei servizi sociali». In questi Comuni, insomma, non si spende per mense, tram e bus, ma per altro che di sicuro non incide sulla qualità della vita dei residenti. Il che rimanda inevitabilmente a un aspetto, su cui pochi hanno insistito, relativo all’ultima classifica del Governance Poll del «Sole 24 Ore». I curatori del sondaggio hanno infatti rilevato, ed è la prima volta che accade, un significativo slittamento di gradimento dai governatori ai sindaci. «I sindaci perdono consenso mentre questo trend risulta meno marcato tra i presidenti di Regione», ha scritto Antonio Noto che dei curatori è il capo. E Noto ha spiegato che il calo interessa solo un governatore su due contro tre sindaci su quattro. Nel caso dei sindaci, poi, ha fatto notare che, «quando il calo è così generalizzato non sono solo le capacità del singolo amministratore a essere oggetto di valutazione, ma la funzione stessa e i poteri a lui assegnati». Sulle cause di questo slittamento, Noto ha potuto naturalmente fare solo delle ipotesi. Una, probabilmente la più importante, è che sia stato proprio il dibattito sull’Autonomia differenziata a dare visibilità ai presidenti di Regione; un’altra è che a esaltare il protagonismo di questi ultimi sia stata – nel bene più che nel male – il ruolo giocato nella drammatica stagione pandemica. In ogni caso, «i presidenti di Regione sembrano contare di più e, di conseguenza, trasferiscono l’impressione di poter meglio determinare la crescita di un territorio, il suo sviluppo infrastrutturale e l’implementazione dei servizi». Giusto? Sbagliato? In ogni caso, il quadro è questo. Puntare sui Comuni si può. Portarli a modello di efficienza non sempre conviene.